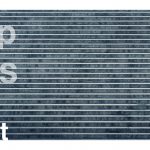(Spielberg 2017).
The Post è un bel film. Non tanto per la storia, che è la solita storia di documenti trafugati e ingerenze del governo sugli organi di stampa (narrata con la linearità elegante dello Spielberg); quanto piuttosto per il modo usato per raccontarla. D’altronde è un film profondamente, tautologicamente spielberghiano, con tutte quelle cose che fanno gli stilemi del regista: le musichine accattivanti (che fanno sembrare la scena della fotocopia dei papers un po’ come un’impresa di Indiana Jones), la regia perfetta (una bellissima dialettica dei piani), la suspense assicurata, i personaggi così dannatamente cinematografici da sembrare usciti da un manuale (tipo intoccabili di Brian De Palma per intenderci). Ma questo era tutto abbastanza scontato. La cosa veramente bella di The Post è che NON È in realtà un film su documenti trafugati o tutte le menate che ho detto prima, ma un’opera nostalgica sul funzionamento novecentesco di una redazione, sulla poetica materialità che sta(va) dietro alla costruzione di un giornale, fatta di caratteri mobili, di telefoni a cornetta, di scatoloni pieni di cartacce da ordinare, di redazioni fumose di sigarette, di orari fissi per andare in stampa. Tutti questi elementi sono il vero senso di The Post, che si apre come finestra nostalgica su un mondo che non c’è più, un mondo dove estetica ed etica – giustamente – si interfacciavano con la certa pesantezza della rotative, ché se a mezzanotte non andavi in stampa fine della fiera e buonanotte ai suonatori.
Il post su The Post è dedicato a Selene Tosetto Costabel, Simona Graceffa e Rocco Crea.